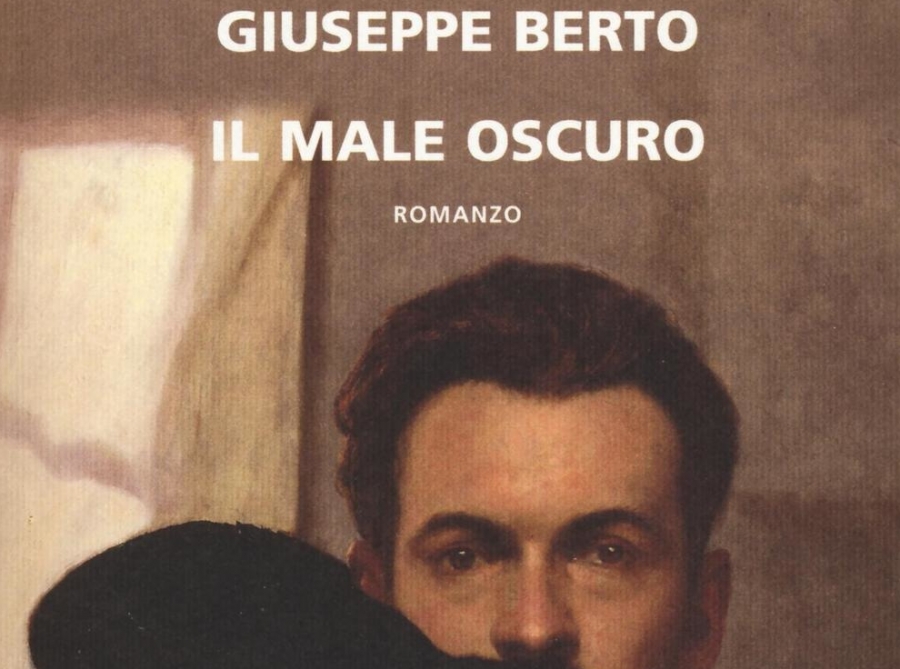I dati ufficiali raccontano di ben quattrocento milioni di persone nel mondo che soffrono di depressione. Anche questa parola abusata e indagata con i criteri della genetica che la porta a considerare come una patologia organica la quale, pertanto, deve essere curata con i farmaci. Ma c’è un’altra via (per fortuna) per misurarsi con il “male oscuro”; consistente nell’analisi del contesto storico in cui la persona ha sviluppato quel profondo dolore dato dal senso di colpa. Tale strada è analizzata dalle avanguardie della psicoanalisi con il mettere al centro l’ambiente in cui si vive e si sviluppano le “malattie”. Un ambiente che in qualche modo tarpa i bisogni più autentici della persona costretta in tal modo a ripiegare in se stessa chiudendosi al mondo e alla vita. Nella seguente considerazione vedremo più nel dettaglio cause e rimedi della depressione.
Secondo dati universalmente diffusi in rete, la depressione è ormai la seconda patologia a livello globale, dopo le patologie cardiocircolatorie. Nel solo mondo occidentale o occidentalizzato, si contano circa 400 milioni di persone che hanno avuto o hanno in corso un episodio di questo tipo.
La prevalenza della cosiddetta “depressione maggiore” (depressione grave priva di riscontri traumatici) e della distimia (variazione ciclica dell’umore) nell’intero arco della vita è pari all’11,2% della popolazione globale. La depressione unipolare (senza passaggi nella mania) ha una diffusione statistica mondiale variabile fra il 5 e il 25%
Il disturbo bipolare (o malattia maniaco depressiva) può coinvolgere dal 10 al al 25% della popolazione mondiale e rappresenta la sesta causa di invalidità nelle persone tra i 15 e i 44 anni, oltre a costituire la causa più comune di disabilità. Se si sommano i dati relativi a depressione maggiore, depressione unipolare, disturbo bipolare si arriva ad un percentuale che oscilla fra il 25 e il 50% circa della popolazione globale. Si tratta di un numero impressionante. Come ho già detto, il totale di persone affette da almeno un episodio grave di depressione o di depressione maniacale nel corso della vita è, a livello mondiale, di circa 400 milioni di persone.
Se non adeguatamente curata, è associata ad una elevata mortalità stimata intorno al 15%, sia per un aumentato rischio suicidario che per una maggiore probabilità di sviluppare patologie sistemiche, come disturbi cardiovascolari, malattie neoplastiche o abuso e dipendenza da alcol e sostanze. Circa un milione di persone ogni anno si toglie la vita, in conseguenza più o meno diretta di episodi depressivi o maniacali. Il grado di invalidità permanente al lavoro nonché alla vita sociale e affettiva è altrettanto elevato.
Anche laddove non invalida in modo permanente o non uccide, la depressione fa comunque molto male. Essa coinvolge la mente tanto quanto il corpo. Il depresso è triste, desolato, disperato, lamenta qualcosa di irreparabile; il suo corpo è ora freddo, inerte, stanco, prostrato, ora invece è fin troppo caldo, rabbioso, rivendicativo, come in preda a uno stato febbrile. Non di rado, il depresso presenta i più svariati sintomi psicosomatici (cefalee, nevralgie, dolori muscolari e articolari, dolori precordiali, patologie gastrointestinali, acufeni, infiammazioni, cali immunitari, ecc. ecc.) che aggravano il suo stato.
Accanto alle patologie ansiose, è la più frequente causa di sofferenza mentale.
Basterebbe il dato impressionante di una patologia mentale che coinvolge un numero variabile di individui fra il 25 e il 50% per capire che non può trattarsi di una patologia genetica. Se a questo dato si aggiungesse il 30% circa di popolazione più coinvolta da esperienze di ansia grave e di panico, nonché il numero esorbitante di persone che soffrono di dipendenze patologiche da sostanze (psicofarmaci, alcol, droghe) il numero dei malati supera ampiamente quello dei sani.
Ebbene, su un piano evoluzionistico è letteralmente impossibile che una specie con questi numeri avrebbe potuto competere con specie ben più fortunate. Si sarebbe estinta prima di raggiungere una qualunque forma di maturità biologica. L’unica spiegazione possibile di questa anomalia è che Homo sapiens si sia affermato quando ancora era un animale relativamente sano, poi che abbia sviluppato società così disfunzionali che la patologia mentale è diventata inevitabile. Dunque, in sintesi, la patologia mentale è dovuta all’impatto di individui biologici potenzialmente sani con società grossolanamente malate.
Che i disturbi psicopatologici siano di natura genetica, quindi delle mere disfunzioni e che riflettano di un crollo delle facoltà psichiche privo di senso e di funzionalità è un concetto sbagliato: una triste eredità della psichiatria organicista; concetto che, fra l’altro, alimenta la giù grave disperazione delle persone.
Il nucleo sintomatologico presente in ogni depressione è costituito da sintomi psicosomatici come astenia, apatia, abulia, estrema faticabilità, rallentamento dell’ideazione e psicomotorio, mancanza di concentrazione, appiattimento emozionale, confusione mentale e amnesia, rigidità dei movimenti, una relativa disconnessione tra volontà e azione, ecc. Ebbene, tutti questi sintomi sono facilmente riconducibili ad un’inibizione funzionale, ossia ad un comando del sistema nervoso centrale che impone a mente e corpo un blocco delle funzioni di attivazione. Il depresso si cristallizza, si pietrifica, si immobilizza o giace in un torpore sonnolento, paralizza ogni volontà di azione; quindi si inattiva. Questo è il nucleo sintomatico di ogni depressione. Su questo stato psicosomatico basilare si impone l’apparato cognitivo, l’esperienza che il soggetto fa della sua condizione, con le sue valutazione e deduzioni. A questo secondo livello, la depressione psicosomatica viene gravata di un pesante fardello noetico, cognitivo. Si sono aggiunti pensieri negativi, infine catastrofici, che aggravano e mettono sotto minaccia un a personalità che con lo stato psicosomatico si stava semplicemente difendendo.
Come ogni altro disturbo psicologico, anche la depressione ha origine nello sviluppo della persona, ha un significato di sintesi emotiva delle vicende esistenziali personali e ha una soggiacente – anche se di solito misconosciuta – funzione protettiva di adattamento.
La depressione si attiva in rapporto a due emozioni negative di base: il senso di colpa e la vergogna. Quindi, come esiste una depressione da senso di colpa – la più descritta, in letteratura –, esiste anche una depressione da sentimento di vergogna. Nello stato depressivo ordinario sono spesso coinvolti in modo confuso sentimenti di delusione e di vergogna per non aver raggiunto ideali sociali o morali molto elevati, spesso irrealistici, e sensi di colpa dovuti alla rabbia – conscia o inconscia – nei confronti di persone e valori amati.
La depressione da vergogna nasce in rapporto a ideali dell’Io iper-esigenti e costituisce una sorta di freno all’autosfruttamento esistenziale imposto da questi valori ideali. La depressione da senso di colpa nasce da conflitti radicali, sia interpersonali che intrapsichici, ed esprime il blocco delle cariche aggressive conflittuali, lesive dei rapporti affettivi e sociali coinvolti e quindi della propria immagine morale. In entrambi i casi, la depressione è funzionale, serve a qualcosa, protegge l’individuo ora dall’autosfruttamento, ora dall’attivazione di moduli aggressivi e dei conseguenti moduli intrapsichici punitivi. Esprime dunque una chiara funzione di adattamento.
Se il soggetto depresso non riesce a capire qual è la funzione specifica, personale e non generica, della sua depressione, dovrà farlo il suo terapeuta. In entrambi i casi, se non si comprende a cosa serve, il disturbo è destinato a perpetuarsi e a cronicizzarsi. Con la cronicizzazione, esplodono le previsioni catastrofiche e, con esse, il rischio di autolesionismo, condotte antisociali e suicidio.
In questo senso, la psichiatria organicista (quella del DSM, per intenderci) non solo sbaglia, ma non di rado crea un danno irreversibile ai suoi pazienti e all’intera cultura della salute. Formulando la diagnosi di malattia genetica, induce o aggrava la previsione soggettiva di inguaribilità, quindi lo stato di angoscia; stato cui il paziente oppone rimedi sempre più patologici: la crescente dipendenza farmacologica, l’abuso di sostanze come l’alcol, l’autolesionismo fisico e, in casi estremi, il suicidio. Si può parlare allora di una patologia iatrogena, ossia provocata dalle stese cure.
Anche alcune psicoterapie agiscono nello stesso modo laddove vedono nel sintomo null’altro che un danno da fattore endogeno intrinseco, come una pulsione aggressiva innata, o da fattore esogeno, come un presunto trauma precocissimo non memorizzato. Se il paziente non può intervenire attivamente sulla sua patologia, si sente impotente e finisce per attivare una dipendenza sine die dal terapeuta.
A livello giovanile, la depressione dipende spesso dalla convinzione di avere tradito le aspettative di qualcuno: genitori, insegnanti, gruppo dei pari. Mentre un tempo il ragazzo e la ragazza incorrevano in una depressione perché tradivano la fiducia dei genitori, oggi sempre più spesso sono coinvolti da insegnanti troppo esigenti o anche più spesso dal gruppo dei pari, che chiede l’assunzione di modelli che il giovane non riesce a incarnare. È sempre meno la famiglia a determinare i valori di riferimento, e sempre più agenzie sociali esterne come la scuola e il gruppo di riferimento. Di conseguenza, anche il crollo dell’immagine personale a fronte degli ideali e dei valori interiorizzati ha sempre meno lo sfondo familiare e sempre più lo scenario pubblico.
Quindi spesso l’avvilimento giovanile è mascherato da comportamenti sfidanti, sia all’interno della famiglia che sul palcoscenico del mondo; comportamenti che vanno dall’assunzione di alcol e droghe fino a varie forme di autolesionismo. Vero o no che sia, è in tutti questi casi il giudizio sociale percepito – quindi la vergogna – che fa scattare il vissuto depressivo giovanile.
A margine di questa tendenza maggioritario, troviamo depressioni più specifiche, quale quella dell’introverso ipersensibile che, certo di non essere all’altezza dei nuovi valori sociali, sempre più esibitivi, cinici e sprezzanti, si isola nella sua torre d’avorio, dove coltiva lo studio, la cultura, le sue passioni personali; oppure, a livelli gravi, l’inerzia, l’abulia, l’apatia, che celano un mondo interno ricco di valori emotivi, immaginazione, talvolta vera genialità.
Per quanto riguarda il tipo psicologico, la depressione colpisce soprattutto l’individuo sensibile, il quale per la sua complessa natura si è legato intensamente, ma è stato frustrato e deluso. Egli ha subito una pedagogia inadeguata e quindi sfruttamento diretto o indiretto e traumi di vario ordine e nondimeno, per bisogno affettivo, ha sviluppato una estrema dipendenza relazionale. Quindi ha appreso a reagire con un misto di desiderio compiacente e di rabbia oppositiva nei confronti delle persone amate, dei gruppi sociali, talvolta nei confronti dell’intera umanità.
Altre volte l’individuo sensibile ha interiorizzato con viva partecipazione codici sociali opposti alla sua natura intima e partecipativa. In questo caso sono i valori interiorizzati – quindi gli ideali dell’io – che ponendosi come suoi tiranni hanno finito per sfruttarlo e deluderlo. Anche in questo secondo caso, la sensazione di disporre di strumenti sbagliati o di non avere affatto strumenti con cui affrontare la vita induce in lui un odio generico per la vita stessa e per l’umanità.
Questo odio gli viene imputato dal Super-Io come segno non della sua estrema sensibilità, ma della sua indegnità morale, in un processo che dalla colpa lo può portare infine all’annichilimento. È chiaro che più è elevata la sua sensibilità morale, più è probabile che il danno depressivo sia profondo.
Se non si smonta l’apparato accusatorio e la rabbia sepolta che lo alimenta, lo stato depressivo non cede nemmeno agli psicofarmaci. Questi, allentando il nodo delle emozioni di rifiuto e di auto-accusa, possono dare un temporaneo sollievo. Ma se non sono efficaci – e lo sono sempre e solo per caso, non potendosi mai prevedere le variabili della soggettività – allora occorre aumentarne i dosaggi o cambiarli, con effetti imprevedibili.
La depressione va quindi curata sul piano psicoterapeutico, coadiuvato da qualche farmaco solo in situazioni gravi ed emergenziali.
La prima cosa da fare è valutare se il paziente abbia subito effetti iatrogeni, cioè se i pregressi interventi clinici gli abbiano indotto la sensazione o l’idea delirante che la sua malattia sarà perpetua e inesorabile e che quindi per tutta la vita sarà un minorato. Questa sensazione di essere soggetti a un destino inesorabile è molto più frequente di quanto non si pensi, per due motivi: primo, perché il soggetto stesso è depresso proprio perché tende a colpevolizzarsi; secondo, perché la cultura psichiatrica corrente lo conferma nell’idea di essere davvero negativo e sbagliato, e di esserlo nella sua radice più intima e meno controllabile: la sua natura genetica. Quando ciò sia avvenuto, occorre spiegare, spiegare e spiegare che ciò è falso (sbarazzandoci di certi “cattivi maestri” psicoanalitici, i quali proibiscono al terapeuta di dare al paziente alcuna forma di “spiegazione”, perché questo sarebbe troppo “pedagogico”).
Fatto questo, finalmente si potrò avviare la psicoterapia in senso proprio. Allora, i passi da fare saranno questi: 1) innanzitutto scoprire “chi è il persecutore”, ossia quale parte della personalità – Super-io o Io antitetico – lo tormenti con le sue richieste e con le sue accuse, se quindi si tratti di una depressione da senso di colpa o da sentimento di vergogna.
2) Quindi, secondo passo, analizzare i valori che il depresso ha interiorizzato e si impone, che il più spesso sono ideali non realistici se non del tutto irraggiungibili. A volte sono ideali di bontà sacrificale, che lo destinano alla soggezione e allo sfruttamento; altre volte sono ideali di prestazione sociale, che lo destinano all’autovalutazione ossessiva e alla vergogna.
3) Terzo passo, far emergere la rabbia repressa che ha per oggetto quei valori e ovviamente le persone concrete che glieli hanno trasmessi e mostragli come quel rifiuto possa aver un valido fondamento.
4) Quindi quarto passo, considerare il terribile senso di colpa associato al rifiuto che fino ad ora ha opposto e quindi smontare l’attrezzatura ipercritica che ha adoperato contro se stesso.
5) Quinto passo, infine, far emergere l’Io originario, la intrinseca innocenza, quindi mettere a contatto i bisogni naturali di questo Io con nuovi valori che diamo al paziente un sentimento di possibilità e uno spazio di evoluzione.
Questi cinque passaggi sono fondamentali; ma il secondo e il terzo sono i più importanti. La depressione dipende sempre da rabbia sepolta, anche quando essa non appare alla coscienza. Può essere una rabbia molto antica e strutturata nella personalità; oppure riferita a eventi recenti. Di solito, quando sfugge alla coscienza, ciò dipende dalla sua antichità o da una rimozione che impedisce di ammetterla e di sperimentarla.
Risolto il velo di tenebra, al di là della depressione si scoprirà che esiste un mondo nel quale la condanna alla mortificazione perpetua non solo non ha fondamento, ma è il frutto di una rabbia morale e di una conseguente autocritica esasperate, persino spietate; è il frutto di una guerra intestina non pacificata.
Da questa guerra intestina ci possiamo liberare dalla colpa solo conquistando una relazione umana con noi stessi e con gli altri, nel mondo affettivo, sociale e culturale; dove trovare il nostro posto, il nostro significato, quindi la nostra personale individuazione.